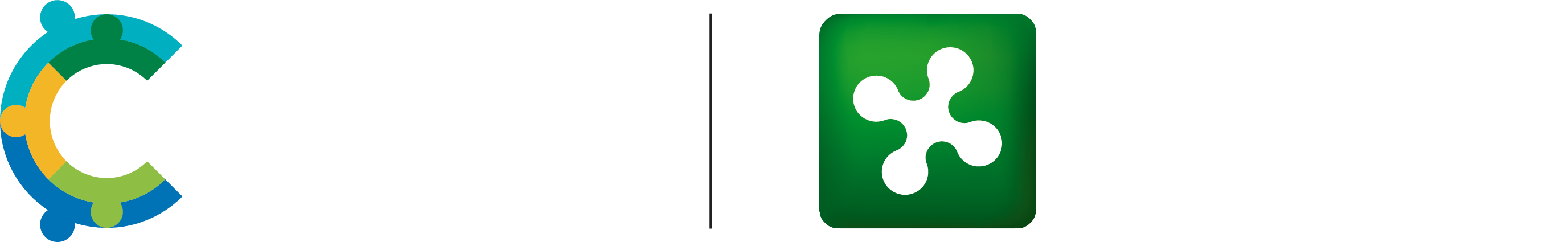Come accennato nell’articolo precedente, per il giovane adulto percorrere la “seconda traiettoria” (accettare i propri limiti e quelli della realtà esterna) è oggi una sfida complessa date le numerose trasformazioni economiche, sociali e culturali del mondo occidentale.
Ostacoli interni ed esterni
Apparentemente in modo paradossale, un contesto sociale che offre tante opportunità può favorire il prolungamento dell’adolescenza perchè collude con le illusioni infantili di illimitatezza del giovane, ma al contempo non è capace di sostenere e soddisfare concretamente tali fantasie.
Inoltre, il processo di accettazione delle rinunce, dei limiti e delle perdite di cui sopra necessita di un profondo e talvolta doloroso percorso di acquisizione di alcune nuove capacità, come quella di fronteggiare la nostalgia regressiva per l’infanzia, l’angoscia di separazione dai genitori, la tolleranza alla frustrazione data dalla possibilità di non soddisfare le richieste degli ideali interni (Jeammet, 2008).
Dai meccanismi di difesa al blocco evolutivo
“Uno scacco nella nascita come soggetto sociale”
Se durante l’adolescenza viene incoraggiata la sperimentazione, nell’età adulta non c’è più tempo di sperimentare: bisogna prendersi le responsabilità delle proprie scelte, azioni ed eventuali errori. Quando nell’individuo mancano le sicurezze interne che lo proteggono e lo sostengono in questo processo, la presa di responsabilità diviene spaventosa e innesca alcuni meccanismi di difesa atti ad impedirla.
Se scegliere e responsabilizzarsi significa poter sbagliare, e sbagliare evoca un’elevata quota di paura sofferenza, come difendersi?
“Chi non fa, non sbaglia”, recita un celebre detto, che in termini “tecnici” si traduce nella sempre più crescente tendenza al ritiro da parte dei giovani. In altre parole, è meno rischioso isolarsi, fare nulla, restare in stallo che confrontarsi con il fallimento che un investimento sbagliato potrebbe comportare.
Ciò esita in un prolungamento dell’assetto adolescenziale, una confortante (ma in modo illusionale) posizione di “non scelta” e quindi di “non errore”.
Alcuni autori parlano proprio di “Adolescenza Prolungata” per riferirsi a quella situazione di blocco del processo di sviluppo ad ampio raggio: l’identità rimane incompleta (e fragile), e gli investimenti lavorativi e relazionali sono sospesi o ancora vissuti nell’ottica della sperimentazione (dove prevale, quindi l’incostanza).
Relazioni insoddisfacenti
Diversi autori si sono espressi sui “compiti” che il Giovane Adulto deve portare a termine in ambito relazionale. Erikson (1968) ad esempio pone al centro la capacità di condivisione amorosa, nei termini di costruzione di un rapporto intimo e impegnato, che contempla sacrifici e compromessi.
Similmente Fornari (1975) parla della necessità di spostarsi dalla “pulsione di appropriazione” alla “pulsione di scambio”, ponendo quindi enfasi sul tema della reciprocità e su quello della progettualità di coppia. Reciprocità che Pietropolli Charmet (2007) traduce nei termini di responsabilizzazione nei confronti del partner e del suo destino.
“Non puoi stare bene con l’altro se prima non stai bene con te stesso”, recita un celebre detto popolare, che applicato al tema che stiamo trattando significa: “se prima non conquisti le tappe di sviluppo relative alla costruzione delle tue sicurezze e al consolidamento della tua identità, difficilmente potrai vivere una relazione realmente appagante per te e per il/la tuo/a compagno/a”.
All’interno di una rapporto di coppia la paura di “perdere se stessi” viene intensificata dalla necessità di trovare compromessi, “fare passi indietro” e talvolta “sacrificarsi”: vien da sè che, a fronte di un’identità non ancora consolidata e strutturata, la relazione può diventare un amplificatore del disagio del Giovane che, non ancora sicuro del suo “Sè personale”, si ritrova contemporaneamente a dover costruire un “Sè sociale/relazionale”.
Conclusioni
La fase del Giovane Adulto è dunque un momento della vita estremamente faticoso e difficile, che porta spesso con sè una significativa quota di sofferenza. Non è un caso che in Italia la fascia di età maggiormente rappresentata, tra le persone che si rivolgono ad uno psicologo, è proprio quella 18-40.
Nel prossimo articolo vi parleremo più dettagliatamente di questo tema, e di cosa fanno i professionisti della salute mentale per affrontarlo. Buona lettura!